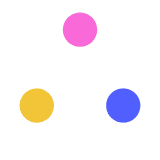
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
eugenia22.bel
Created on December 29, 2020
More creations to inspire you
LIBRARIES LIBRARIANS
Presentation
WORLD WILDLIFE DAY
Presentation
FOOD AND NUTRITION
Presentation
IAU@HLPF2019
Presentation
SPRING IN THE FOREST 2
Presentation
HUMAN RIGHTS
Presentation
BLENDED PEDAGOGUE
Presentation
Transcript
START
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
La Grande Guerra scoppiò nell’estate del 1914 e terminò nel novembre del 1918. Si cominciò a chiamarla così non solo perché stava durando molto più del previsto, ma anche perché era diventata una grande “macchina” che produceva continuamente nuove vittime, cioè un'industria di morte.
La scintilla scatenante la Grande Guerra fu l’attentato all’ arciduca d’ Austria, Francesco Ferdinando, e a sua moglie, avvenuto a Sarajevo il 28 giugno 1914. Ma altre cause vi erano.
Le cause
L'entrata in campo degli Stati Uniti e la "Rivoluzione d'ottobre" con la conseguente uscita della Russia dalla guerra
Attacco sul fronte italo-austriaco
Entrata dell'Italia in Guerra
Scoppio della Prima Guerra Mondiale
1914
1918
1916
1917
Termina la Prima Guerra Mondiale
1915
Timeline
- La battaglia di Tannenberg
- La battaglia della Marna
- La battaglia di Verdun
- La battaglia della Somme
- Le 12 battaglie dell'Isonzo
- Le battaglie del Piave
Le battaglie più importanti della Grande Guerra
I trattati di pace
Grazie alle industrie di armamenti, l'economia si sviluppò molto. Anche la scienza fece passi in avanti. Nel conflitto si sperimentarono per la prima volta armi nuove come il carro armato e i gas tossici. Il 22 Aprile 1915 nei pressi di Ypres in Belgio i tedeschi spruzzarono contro le trincee occupate dai francesi un terribile gas a base di cloro, chiamato “iprite”. Mostrarono tutta la loro importanza strategica anche i sommergibili. La scienza e la tecnologia si applicarono anche alla medicina di emergenza. Grazie al premio Nobel Marie Curie vennero costruiti apparecchiature radiologiche montate su veicoli; un capitano medico dell'esercito americano scoprì invece che il sangue poteva essere conservato. Nacquero così le prime banche del sangue.
Economia e progresso scientifico durante la Grande Guerra
Le fonti dirette per capire la condizione dei soldati durante la Grande guerra sono fondamentalmente quattro.
Le fonti
Le fonti dirette per capire la condizione dei soldati durante la Grande guerra sono fondamentalmente quattro.
Le fonti
Per quattro anni, milioni di soldati furono costretti a convivere in cunicoli e trincee, al sole cocente o al gelo secondo le stagioni, sotto il fuoco delle mitragliatrici, in condizioni igieniche disastrose, uscendo solo durante gli attacchi e dormendo poco e male. Le battaglie portavano sempre, anche tra i vincitori, morti, feriti e mutilazioni. La vista di decine di cadaveri, abbandonati per ore prima di essere portati via, divenne del tutto normale.
I soldati in Guerra
Il kit di equipaggiamento dei soldati comprendeva anche le posate e la gavetta, un recipiente di metallo usato per riscaldare e mangiare le razioni.
-L'uniforme-L'elmetto-L'elmetto a farina-Berretto -Maschera antigas-Buffettiera-Tascapane-Zaino-Scarponi
Il kit d'equipaggiamento dei soldati
Durante la guerra la popolazione non riusciva a nutrirsi in maniera adeguata, tant'è vero che si diffusero molte malattie provocate da gravi carenze alimentari, come la pellagra. Uscirono moltissimi libri di cucina con le ricette per tempi di guerra e s’inventarono le frittate senza uova e il pane con la farina di ghiande.
La cucina al tempo della Guerra
La guerra cambiò il modo di vivere dei bambini. In classe venivano dedicate molte ore alle letture patriottiche; invece della ginnastica si facevano esercitazioni che ricordavano quelle dei soldati. Si studiavano le armi e si parlava dei gas asfissianti. Nei negozi di giocattoli gli animali di pezza avevano ceduto il posto a piccoli fucili giocattoli. I giornalini, a cominciare dal più famoso il “Corriere dei piccoli”, erano pieni di storie eroiche di bravi bambini che si comportavano come ometti coraggiosi e pieni di amore per la patria.
I bambini
Con gli uomini chiamati al fronte, molte donne durante la guerra cominciarono a lavorare nelle fabbriche. C'era bisogno di uniformi, di munizioni, delle tante cose che servivano in un conflitto. La produzione doveva tenere un certo ritmo e gli operai maschi esonerati dal fronte non erano sufficienti. Le donne così iniziarono a svolgere anche i lavori più duri e faticosi.
Le donne
Le donne più colte o benestanti, quelle che non avevano bisogno di mantenere la propria famiglia, si dedicarono alle attività benefiche e sociali. Divennero infermiere volontarie, si occuparono dei profughi, fondarono comitati di assistenza per vedove e orfani.
L'assistenzialismo delle donne durante la guerra
La guerra accellerò lo sviluppo dei media e l'importanza che questi ebbero durante il conflitto. Si parlò di manipolazione delle notizie, realizzata spesso direttamente dai generali o dai segretari di stato. Quello del giornalismo durante la guerra fu un percorso ad ostacoli tra le necessità della propaganda e la scure della censura.
La Grande Guerra e i mass media
Lo stupore suscitato da un evento eccezionale e senza precedenti come la Prima Guerra Mondiale spinse molti intellettuali a creare opere ispirate alle sue contraddittorie vicende. Memoriali, diari, poesie, romanzi raccontavano le impressioni e i sentimenti suscitati dalla guerra. Nacquero dei capolavori, come le liriche di Giuseppe Ungaretti raccolte ne "Il porto sepolto", o best seller mondiali, come "Addio alle armi" di Ernest Hemingway. Molte opere nacquero alcuni anni dopo la guerra e rappresentarono una dolorosa riflessione a posteriori condotta dall’artista.
La letteratura e la Grande Guerra
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale molti giovani artisti decisero di arruolarsi come volontari. La loro decisione fu motivata sia dall’entusiasmo culturale, come nel caso dei futuristi, sia dalla voglia di documentare i fatti con disegni e dipinti. Le opere di questi giovani forniscono un importante documento dell’epoca e rappresentano un diario personale nel quale si trovano luoghi, ritratti di amici e paesaggi.
L'arte e la Grande Guerra
Negli anni compresi tra il 1914 ed il 1918 i caricaturisti parteciparono alla guerra mettendo il loro talento a disposizione dei rispettivi governi. Se in precedenza facevano una critica feroce contro gli uomini politici, ora si trasformarono nella punta di diamante della propaganda nazionale contro i nemici, sempre rappresentati con caratteristiche fisiche, umane e morali che ne facevano personaggi spregevoli e ripugnanti in contrapposizione ad un'immagine dei propri concittadini, moralmente impeccabile ed idealizzata.
La Satira
Una delle tante eredità che una guerra lascia ai posteri è quella delle canzoni. Da sempre infatti la musica ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia. Accompagnate da un testo facilmente memorizzabile vennero composte per aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo, per sollevare gli animi oppure per esorcizzare la paura della morte sempre in agguato. I testi raccontano le gesta di un battaglione, il dolore per i lutti; descrivono i luoghi delle battaglie oppure le speranze di rivedere la propria amata che aspetta il soldato a casa.
L'eredità della Grande Guerra: le canzoni
Memoria della Grande Guerra: il Milite Ignoto
Il Milite Ignoto è un militare morto in guerra il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati.
L’argomento “La Grande Guerra” mi ha colpito molto perché mi ha fatto conoscere una parte drammatica della storia umana. Mi è rimasta impressa la forza con cui le donne hanno saputo adattarsi andando avanti da sole. Sono riuscite a fare anche i lavori più pesanti senza mai arrendersi e senza lasciare i propri figli morire di fame. Mi ha fatto riflettere il dolore e l'angoscia dei soldati da soli nelle trincee, accompagnati dal solo pensiero della morte o dalla sola speranza di rivedere i propri cari. Mi sono fatta una domanda: “A che cosa serve la guerra?” Non sono riuscita a darmi una risposta, perché la mia mente mi porta a pensare che tutti i conflitti si possano risolvere solo con il dialogo e la diplomazia, senza usare le armi e la violenza.
Cosa ne penso...
Le connessioni
La Grande Guerra non mi sembra tanto diversa dalle guerre che si stanno combattendo oggi, per esempio in Afganistan o in Siria. Le cause e gli effetti sono sempre gli stessi. A scatenare la violenza umana, oltre le divergenze religiose ed etniche, sono sempre gli interessi economici, politici e di potere; a rimetterci sono sempre le popolazioni, i bambini e le donne, che vivono ogni forma di violenza e di privazione. La vita sociale ed economica è inesistente. Mangiare, curarsi o lavorare, oppure semplicemente giocare e andare a scuola è impossibile. Così come allora anche oggi i bambini vengono arruolati nei campi di battaglia, smettono di vivere la loro infanzia; le donne invece oltre a subire continue violenze e a vedere negati i propri diritti civili, devono comunque farsi forza per difendere i loro figli e portare avanti la loro famiglia. Insomma la realtà drammatica della guerra, in qualsiasi tempo sia vissuta, è sempre la stessa. Bisogna ricordare che oggi si è rischiato di vivere una terza Guerra mondiale a causa delle continue divergenze tra USA e Iran.
Libri e film
